Donne e lavoro. Rivoluzione in sei mosse di Rita Querzè (PostEditori) è un libro che si pone un obiettivo ambizioso: non solo raccontare la realtà delle disuguaglianze di genere sul lavoro, ma anche indicare i possibili percorsi concreti per superarle. E lo fa andando a incontrare sul campo le aziende e le donne che hanno messo felicemente in discussione l’organizzazione del lavoro di stampo taylorista, pensata per lavoratori maschi totalmente avulsi dal lavoro domestico.
Una call to action per la politica
I sei capitoli del libro contengono denuncia, rivendicazione e stimoli. Anzi, vere e proprie call to action per imprenditori e imprenditrici, per il sistema finanziario e per la politica. Perché è la politica, sono i partiti che devono rispondere, con le loro agende e i loro programmi elettorali, della mancata applicazione dell’obbligo di congedo parentale di 10 giorni per i padri, che è legge dal 2019, ma è costantemente disatteso. Dei disincentivi fiscali al lavoro femminile, conseguenza del meccanismo perverso degli assegni familiari e delle detrazioni per il coniuge a carico. Dell’assenza di sostegno per esternalizzare il lavoro domestico, come avviene in Francia, dove i benefici fiscali rendono più conveniente avere una colf in regola che pagarla in nero. Della carenza di asili nido: la madre di tutte le battaglie, perché senza asili nido le donne restano inchiodate al lavoro di cura (che ricade su di loro per il 70%) e al part time involontario, che riguarda ben il 60% dei contratti a tempo ridotto.
La disillusione del Pnrr
“Il nido può cambiare davvero la prospettiva delle famiglie solo se è gratuito come la scuola materna”, scrive Querzè, che tuttavia trova incoraggiamento dalla piccola spinta volonterosa del Pnrr, che si era dato l’obiettivo di garantire un posto nido al 33% dei nuovi nati (ma l’UE già punta al 45%): una strada abbandonata con l’ultima revisione del Pnrr che ha tagliato i nuovi posti in asili nido e scuole per l’infanzia gli dagli iniziali 264 mila ad appena 150 mila.
Il tema dei nidi si lega a quello degli orari di lavoro, che non sono scolpiti nella pietra, come dimostra il caso dell’azienda Pennelli Cinghiale che apre il primo capitolo del libro, “Le madri e la finta libertà di lavorare”: una realtà dove le donne sono l’80% e dove l’orario di lavoro è passato, senza terremoti, dal classico 8-12 e 14-18 all’orari continuato 8-16, perché le donne non se ne fanno niente di una pausa di due ore, non avendo nessuno a casa che gli prepari il pranzo, mentre così possono andare a prendere i figli quando escono da scuola. Il capitolo affronta i numerosi limiti che le donne devono affrontare sul posto di lavoro, dal gender pay gap (le donne italiane guadagnano il 15,5% in meno nel privato e il 5,5% in meno nel pubblico) al part time involontario e alle difficoltà nella gestione familiare, anche a causa di condizioni fiscali disincentivanti per il lavoro femminile.
Sessanta ore di lavoro domestico a settimana
Il secondo capito parte dal lavoro di cura, che per cultura nazionale continuiamo ad appaltare alle donne (il 46% degli italiani ritiene che il loro compito sia occuparsi dei figli e della casa), e il fallimento, a oggi, delle norme per il congedo parentale maschile, mentre paesi come la Spagna lo hanno portato a 16 settimane per mamme e papà, di cui 6 obbligatorie, con stipendio al 100%. Per coprire le esigenze familiari, le donne lavorano in media 60 ore a settimana, contro le 47 degli uomini: questo lavoro extra non è riconosciuto, non è valorizzato e non è esternalizzabile a condizioni vantaggiose, perché mancano gli asili nido, perché non viene favorito fiscalmente il ricorso a colf e baby sitter e le rette delle residenze per anziani sono insostenibili, quindi a conti fatti è molto più vantaggiosi che uno dei coniugi si dedichi al welfare familiare. Quasi sempre la donna. “Occorre mobilitare risorse per rendere accessibili tutti questi servizi”, perché non basta una maggior collaborazione da parte dei mariti, ma occorre anche trasformare parte di quel lavoro oscuro in lavoro retribuito, con due vantaggi: liberare tempo per le donne e creare nuova occupazione femminile regolare.
Lavorare di più, guadagnare di meno
Dei sei passi che il libro percorre per ridisegnare il lavoro femminile in Italia, i primi due toccano sostanzialmente questioni di politica economica, che hanno a che vedere con la revisione della spesa per il welfare, in modo da eliminare i disincentivi al lavoro femminile (primo capitolo), e l’emersione del lavoro di cura, che va formalizzato, contrattualizzato e remunerato (secondo capitolo). Seguono due capitoli sul duro confronto con due realtà che resistono al cambiamento. Uno (il terzo) riguarda il divario economico tra lavoratori e lavoratrici: un gap che si manifesta già all’ingresso nel mondo del lavoro, dato che il primo stipendio post laurea vale in media il 16,9% in più per gli uomini rispetto alle donne, a parità di condizioni. Una partenza a handicap che si consolida e si amplia col passare degli anni e il progredire delle carriere. Carriere anch’esse divergenti, che neppure il sostegno legislativo sembra capace di riallineare, come dimostra il caso delle cosiddette quote rosa nelle aziende quotate in Borsa: la legge Golfo-Mosca del 2011 ha certamente ampliato la presenza femminile nei Cda delle aziende, ma non sembra aver generato un circolo virtuoso capace di autoalimentarsi.
Il lavoro di serie A e quello di serie C
Il quinto capitolo del libro entra nei contratti di lavoro e nei percorsi che permettono che norme apparentemente paritarie producano condizioni di lavoro totalmente sbilanciate. Infatti, l’autrice racconta i posti di lavoro di serie A, quelli che prevedono contratti stabili, orari favorevoli alle esigenze del lavoratore e stipendi adeguati – tipicamente i contratti degli uomini – e quelli di serie C – tipicamente femminili – che sono precari, sottopagati e inadeguati nel conciliare lavoro e famiglia. I fattori che hanno strutturato questa realtà sono molteplici e coinvolgono l’evoluzione del nostro sistema lavorativo, dove le professioni meglio retribuite sono appannaggio prevalente dei maschi (come per esempio gli avvocati d’affari) e quelle più precarie sono invece femminili (i negozi di estetista): siamo al sesto e ultimo capitolo, dove si analizzano anche i limiti dell’imprenditorialità femminile. Nel 2013, le imprese costituite da donne erano il 23% del totale, mentre dieci anni dopo, nel 2022, erano il 22,2%: zero progressi e sempre gli stessi limiti, imprese più piccole, più fragili, concentrate sempre nelle stesse nicchie settoriali, centri estetici e cake design, e sottofinanziate, perché hanno un merito di credito più basso. Di nuovo, un modello formalmente in equilibrio, che però riproduce subordinazione anziché generare crescita per tutta la società.
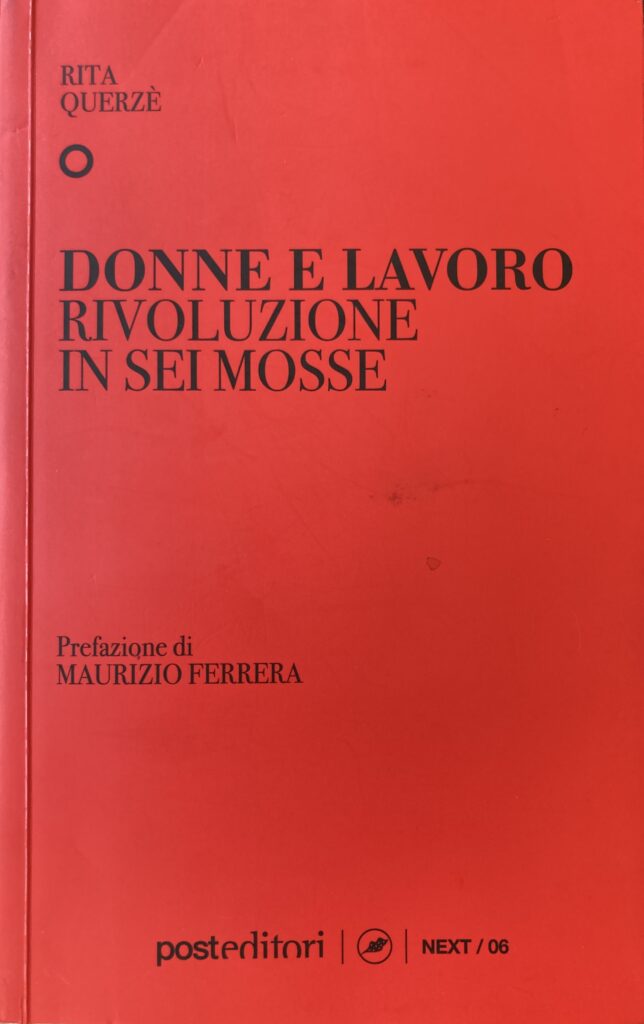
Donne e Lavoro. Rivoluzione in sei mosse, di Rita Querzè, Post Editori, 2023
- Il lato nascosto (e nobile) del gioco gratis: tra marketing e memoria
- Mercati 2026: ottimismo diffuso da Wall Street all’Asia secondo Lemanik
- La prima gamma di fondi goal-based di Unicredit e Blackrock e le altre novità di gennaio tra nomine e fondi
- Calcio: ricavi record per i top club, Real Madrid oltre il miliardo
- La finanza cambia l’albergo: da patrimonio di famiglia a strumento di investimento






